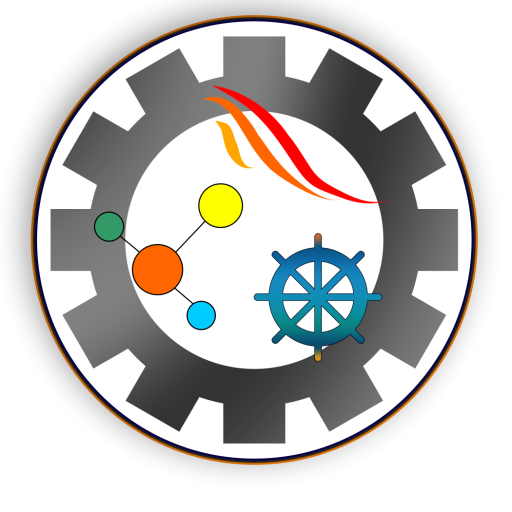In occasione della Giornata della Memoria il 27 gennaio scorso, abbiamo voluto come ogni anno ricordare le drammatiche vicende della Shoah che hanno coinvolto milioni di ebrei mandati a morire con una crudeltà e un’efferatezza che ancora sconvolgono, commuovono e suscitano riflessioni e interrogativi necessari a rendere noi studentesse e studenti consapevoli del valore della convivenza umana, dell’accettazione dell’altro e del rispetto delle diversità. Tale valore trova il suo terreno più fertile nel coltivare e tramandare proprio la memoria di quei fatti. Nonostante la stretta allo stomaco che suscitano racconti, testimonianze, immagini.
Abbiamo rivisto in classe una puntata speciale della trasmissione Caro Marziano del giornalista Pif, trasmessa su Rai Tre il 22 gennaio scorso. Pif ha visitato i campi di Auschwitz e Birkenau e ci ha condotto con mani e cuori tremanti all’interno di luoghi nei quali si è consumata una delle più grandi tragedie dell’umanità. Non è stato facile per lui raccontare ciò che vedeva, non è stato facile per noi entrare attraverso il reportage in luoghi infernali e disumani.
D’altro canto, se è vero che la memoria storica serve come lezione per un presente e un futuro liberi da intolleranze e discriminazioni, è sotto gli occhi di tutti che quotidianamente in vari contesti, sentiamo che nel mondo odierno, l’antisemitismo e l’ineguaglianza, la prepotenza e la sopraffazione continuano a condizionare le vite di moltissime persone per i più svariati motivi. Antisemitismo compreso.
A conferma che quanto accaduto possa ancora accadere.
Oltre a ricordare l’Olocausto e la persecuzione ebraica, abbiamo voluto aggiungere un tassello alla nostra visione storica del passato intrecciandola con quanto avviene nel nostro presente, dall’altra parte del Mediterraneo. Ovvero la guerra israelo-palestinese, che sta vivendo una tregua, ma che dal 7 ottobre 2023 ha causato morti, violenze, distruzioni e drammi umani in Palestina e nella striscia di Gaza soprattutto.
Abbiamo indagato le radici storiche e la drammatica condizione del popolo palestinese. Perché la memoria non conosce etnie e va rinnovata laddove e ogniqualvolta l’uomo smetta di essere umano con il proprio simile.
Il conflitto israelo-palestinese è una delle dispute più lunghe e complesse della storia moderna, con radici che affondano nella fine del XIX secolo e che hanno portato a guerre, occupazioni e tensioni irrisolte.
Il cinema spesso si è fatto portavoce delle sofferenze umane legate a questo conflitto, offrendo punti di vista che mirano a sensibilizzare il pubblico sulle condizioni di chi vive questa realtà ogni giorno.
Due esempi emblematici sono i film “Il giardino dei limoni” di Eran Riklis (2008) e “Private” di Saverio Costanzo (2004) che abbiamo visti in classe, analizzati e dibattuti alla ricerca di significati e messaggi.
Entrambi i film raccontano le difficoltà della popolazione palestinese sotto l’occupazione israeliana.
In particolare, “Il giardino dei limoni” narra la storia di una donna palestinese che si oppone all’esproprio del suo limoneto da parte del governo israeliano, per ragioni di sicurezza del ministro della Difesa. Quel giardino diventa simbolo della perdita della terra, delle radici e dell’identità da parte del popolo palestinese e come tale va difeso con coraggio e determinazione. E che sia una donna a condurre questa battaglia fa sì che quest’ultima diventi una lotta anche contro i pregiudizi e la marginalità del ruolo sociale cui è portata e contro cui si ribella.
“Private”, invece, mostra il dramma di una famiglia costretta a condividere la propria casa con soldati israeliani, che vi si insediano dichiarandola di proprietà dell’esercito per ragioni di sicurezza nazionale. E’ la fine della tranquillità familiare, della libertà domestica insieme ad un acceso confronto fra chi, come il padre, vuole rimanere e i giovani figli vogliono con forza arrendersi, andare via o cedere ad atti di violenza terroristica. La conclusione è amara: ad un gruppo di soldati che vanno via, se ne sostituisce un altro. Non c’è speranza di vivere in pace nella propria casa. Nella propria terra.
Entrambi i film mettono in luce le difficoltà dei palestinesi, suscitando empatia e indignazione. Tuttavia, semplificano una realtà molto più complessa, in cui anche Israele vive con paure e insicurezze legate alla propria esistenza.
Il conflitto, infatti, non si riduce solo all’occupazione, ma affonda le sue radici in decenni di violenze reciproche, dispute territoriali e falliti tentativi di pace. Dalla proclamazione dello Stato di Israele nel 1948 alla Nakba palestinese, dai conflitti armati agli Accordi di Oslo, fino agli scontri attuali tra Israele e gruppi come Hamas, la questione rimane irrisolta. Le principali problematiche della creazione di uno Stato palestinese, il controllo di Gerusalemme, la sicurezza israeliana e il diritto al ritorno dei rifugiati restano aperte, con la comunità internazionale che fatica a trovare una soluzione definitiva.
Il cinema, con opere come “Private”, riesce a dare voce alle sofferenze individuali, ma il conflitto israelo-palestinese è una ferita ancora aperta, il cui racconto necessita di una visione ampia e complessa, capace di comprendere entrambe le parti. Ce ne siamo accorti durante il dibattito nell’indagare le ragioni dell’uno e dell’altro popolo, quanto sia difficile stabilire da che parte stare. E intanto la guerra continua, con il suo carico di dolore e di rancori.
Noi stiamo dalla parte della pace e del dialogo e della possibilità che ogni popolo possa vivere in libertà e nel rispetto della dignità umana.